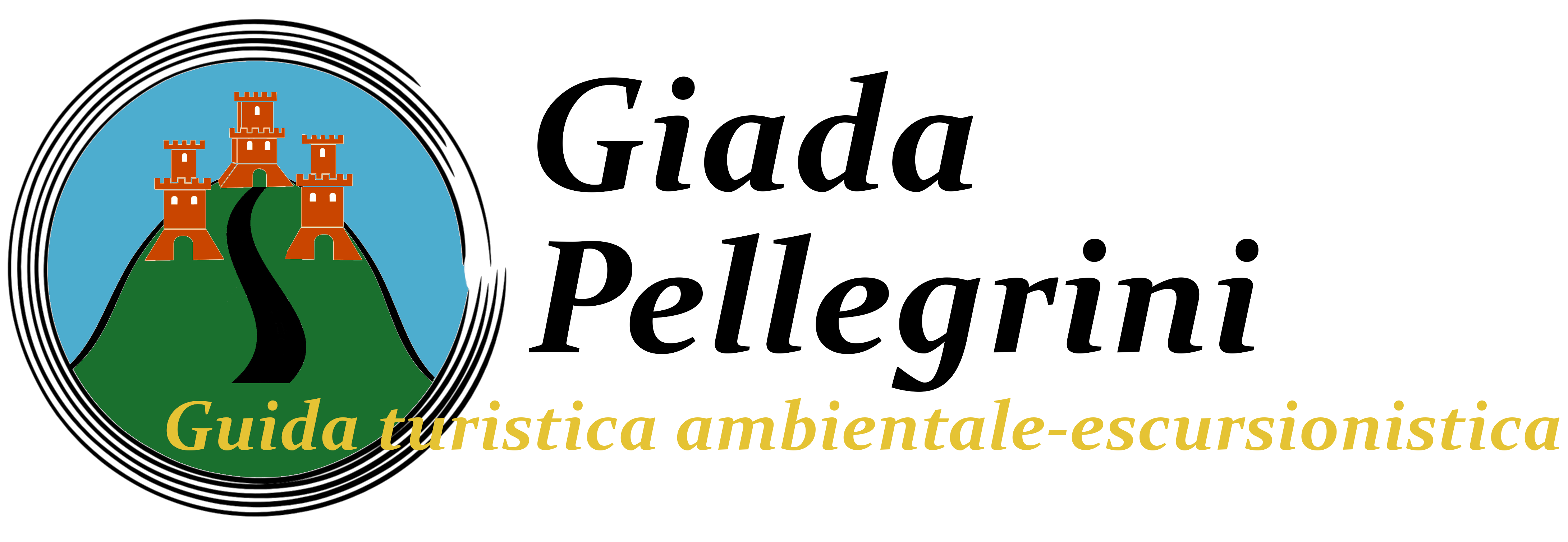L’area delle città del tufo è un lembo di terra nella parte sud-orientale della Toscana e comprende borghi la cui particolarità è quella di essere interamente costruiti sul tufo e con il tufo.
Si tratta dei paesi di Pitigliano, Sorano, Sovana e della città fantasma di Vitozza. Questi centri rappresentano un unicum nel panorama toscano e sorprendono per la loro bellezza fiabesca, per gli scorci inattesi che lasciano senza fiato (anche a me, che ormai vivo qui da diversi anni) e per le interessanti ricchezze archeologiche e naturalistiche.
Sono luoghi che trasudano storia, erano città etrusche di una certa rilevanza in quanto controllavano i traffici commerciale che avvenivano tra l’entroterra e il mare e sono state poi importanti centri politici nel corso del Medioevo e del primo Rinascimento. Ecco, potremmo dire che la storia si è fermata qui.
Il turista che arriva viene catapultato in un passato fatto di conti, di guerre, di vita dura e agreste e si dimentica per un momento di vivere nell’epoca contemporanea.
Negli ultimi anni le amministrazioni locali, d’accordo con la Sovrintendenza toscana, hanno intrapreso diverse iniziative volte alla valorizzazione e conservazione del prezioso patrimonio archeologico presente nell’area e la rinascita di questi luoghi è sicuramente da attribuire al turismo, attratto dalla tranquillità e dalla totale assenza di ritmi frenetici.
La croce e delizia di questi luoghi è sempre stata infatti la lontananza dai centri più importanti, dalle vie di comunicazione più facilmente accessibili perché in passato questo era sinonimo di protezione. Basti pensare a Sovana, che iniziò la sua storia con gli Etruschi, come piccolo centro dipendente da Vulci, dalla quale si ribellò senza successo, ma che finì per diventare municipium romano nel I sec. a.C. e capitale della contea aldobrandesca nel X sec. d.C.

Gli Aldobrandeschi, i signori di Maremma come li definì l’Imperatore Federico II di Svevia, ereditarono Roselle come prima importante città, ma questa era sul mare, soggetta ai ripetuti attacchi dei Saraceni, che la distrussero completamente nel 935 e costrinsero i Conti a rifugiarsi sull’interno. Da Sovana iniziarono a scrivere la storia dei piccoli borghi della Toscana, castelli posti a controllo della grande contea, in continua lotta con i comuni di Orvieto e Siena.
Nell’XI secolo a Sovana nacque anche un importante personaggio…Ildebrando da Suana (nome romano del borgo), tra le personalità più innovative del Medioevo, divenuto papa con il nome di Gregorio VII. Una volta eletto papa nel 1073 darà avvio ad un’opera di riforma della Chiesa, con il suo Dictatus papae affermerà infatti la superiorità del papato su ogni autorità temporale, entrando in aperto conflitto con l’imperatore di Germania Enrico IV. Nota è l’umiliazione di Canossa, evento nel quale l’imperatore chiese perdono al papa, inginocchiandosi, vuole la tradizione, davanti al castello dove il papa si trovava, ospite della contessa Matilde. La tregua durò poco, Enrico IV scese in Italia e assediò Roma, costringendo Gregorio VII a fuggire a Salerno dove morirà, protetto dai Normanni.
Segno del suo passaggio si può trovare nella costruzione del nucleo più antico della Cattedrale di San Pietro, ancora visibile nella cripta, costruita verosimilmente su indicazione del papa, per omaggiare il paese natio.
Le reliquie di Gregorio sono state scoperte nel ‘500 nella Cattedrale di Salerno, tutt’ora custodite lì e portate in rare occasione a Sovana, l’ultima è stata nel 2020.
Per capire la portata rivoluzionaria della figura di papa Gregorio VII basti pensare che nel ‘700 il suo culto verrà proibito all’interno dell’impero e in molte corti europee perché considerato ancora affronto alle potenze imperiali e verrà sostituito dalla figura di San Mamiliano come santo patrono di Sovana e della Diocesi (reinserito solo nel 1947).
Proprio a questo importante personaggio è dedicata la tomba più monumentale della Necropoli etrusca di Sovana, la Tomba Ildebranda, descritta per la prima volta dai fratelli Rosi nel 1925, i quali tentarono di decifrare i pochi resti che affioravano dalla vegetazione. Adesso la Necropoli è inserita all’interno del Parco archeologico Città del Tufo, inaugurato nel 1998, con l’intento di valorizzare le bellezze storiche e archeologiche presenti all’interno del Comune di Sorano.
Visitare la Necropoli etrusca di Sovana è fare un viaggio indietro nel tempo, tra enigmatiche figure incise nella roccia, come la Sirena, la Scilla o il Tifone, manifestazione del sacro mondo etrusco, e strade scavate nel tufo, che arrivano a toccare i 25 m di altezza come nel caso della Via Cava di San Sebastiano. Le Vie Cave sono una particolarità dell’area dei tufi, dove sono concentrate in maniera sorprendente e rappresentano ancora oggi le vie privilegiate per chi vuole muoversi a piedi nei dintorni dei paesi o vuole spostarsi tra Pitigliano e Sovana. Sono la massima espressione del turismo lento, dove la fatica del cammino e la totale immersione nell’ambiente circostante, concorrono nel creare un’esperienza totalizzante.
Prima di lasciare Sovana è necessario fare un salto nel piccolo, ma prezioso, Museo di San Mamiliano dove nel 2004 è stata scoperta un’olla in terracotta, con ben 498 solidi aurei riferibile al V secolo d.C. Questo bel gruzzoletto è stato nascosto in un angolo della piazza di Sovana, dove c’erano delle terme romane in abbandono, con l’obiettivo di salvarle dalla furia devastante delle invasioni barbariche, in particolare dei Goti che nel 410 saccheggiarono la vicina Roma. Il nostro ricco proprietario non tornerà mai a riprendersele, ma attorno a questo tesoro sono sorte leggende che lo hanno accompagnato fino al momento della scoperta.
Il luogo diventerà poi una chiesa, molto probabilmente la prima delle dieci chiese documentate a Sovana, e ospiterà le reliquie di San Mamiliano, vescovo di Palermo ed evangelizzatore della Maremma, oggi conservate nella cripta della Cattedrale. Da questa chiesa, secondo alcuni studiosi, proviene anche il ciborio preromanico databile al IX secolo d.C. che adesso fa sfoggia di sé nella vicina chiesa di Santa Maria. Questo bellissimo altare in marmo è unico in Toscana, non ce ne sono infatti di così antichi, e si può supporre che sia stato acquistato a Roma dagli Aldobrandeschi insieme alle reliquie.
Sovana si trova nel comune di Sorano, il paese di pietra per eccellenza, chiamato la “Matera toscana” e che niente ha da invidiare alla sua sosia.

Dominato dall’alto dalla possente Fortezza Orsini, si presenta come una vera e propria roccaforte. Ancora oggi c’è quasi soggezione nel scendere tra i suoi vicoli e addentarsi nelle Vie Cave circostanti perché si ha sempre l’impressione di essere spiati dall’alto. Infatti doveva essere proprio questo l’intento degli Orsini quando diventano i nuovi conti di Sovana-Pitigliano: difendere la Contea dalla minaccia di Siena e di Firenze, che nel ‘500 affermerà la propria egemonia sulla Toscana, ma anche controllare i propri sudditi. La Contea di Pitigliano, in mano agli Orsini, si dimostrerà un osso duro da piegare proprio grazie a Sorano, vero e proprio paese-fortezza, circondato da profonde forre e raggiungibile solo attraverso profonde Vie cave.
Il paradiso per gli escursionisti, ma anche per pittori, poeti e scrittori. Queste le parole di uno dei letterati più importanti del ‘500, Francesco Sansovino, cronista delle vicende di casa Orsini:
“E’ posto Sorano in luogo piano ed aperto e dalla parte di occidente ha una bellissima veduta e quasi per un miglio si discende per un colle molto ripido all’ingiù; all’incontro del luogo sorge un monte ripido parimenti difficile a salirsi, con alcune lunghe vie scavate nel sasso”
A pochi km da Sorano è possibile visitare Vitozza, chiamata la città di pietra o la città fantasma in quanto fu abbandonata alla metà del ‘400. Di questa città sorta nel Medioevo intorno a uno dei tanti castelli aldobrandeschi, rimangono i ruderi della “Chiesaccia”, di due castelli e le numerose grotte scavate nel tufo.

Un centro rupestre tra i più estesi d’Italia, che ha bisogno di una giornata intera per essere pienamente apprezzato. I più avventurieri possono scendere fino alle sorgenti del fiume Lente e qui ammirare i resti dell’acquedotto ottocentesco, oltre che una natura quasi incontaminata. La parte della città offre invece la possibilità di entrare nelle grotte e con un po' di fantasia, immaginare come vivevano gli uomini del passato. Non uomini trogloditi, ma cittadini con gli stessi doveri e diritti di chi possedeva una casa, ma che avevano scelto uno stile di vita più semplice.
Vitozza fu via via sostituita dalla cittadina di San Quirico di Sorano, anche se alcune grotte più vicine al nuovo centro, furono utilizzate fino alla fine del ‘700 come salnitraie, cave e abitazioni.
Pitigliano chiude la triade delle città del tufo, il suo effetto scenico è senza confronti. Dal santuario della Madonna delle Grazie si ha una vista privilegiata del bancone tufaceo su cui si sviluppano le case, le quali si mimetizzano perfettamente e sembrano essere la prosecuzione naturale della rupe. Al tramonto le calde luci che lo illuminano dal basso fanno somigliare questo paese ad un presepe.

La suggestione è ancora più intensa se si pensa che Pitigliano è conosciuto dalla metà dell’800 come “La Piccola Gerusalemme” per via di una consistente comunità ebraica presente nel borgo a partire dal XVI secolo. Per dare un’idea del numero di ebrei presenti a Pitigliano, basti pensare che rappresentarono, a fasi alterne, un quinto della popolazione totale del paese, stimata indicativamente sulle 4.000 persone.
All’interno del centro storico, lungo Via Zuccarelli, si apre il Museo della Piccola Gerusalemme, inaugurato nel 2003 grazie alla sinergia tra il Comune, che ha restaurato gli ambienti ipogei, e l’Associazione voluta da Elena Servi, l’ultima rappresentante di questa importante comunità, la quale si adopera tutt’oggi al fine di non perderne memoria.
Le stanze che caratterizzano il museo sono tutti ambienti realizzati all’interno del bancone di tufo in epoca protostorica, quando su Pitigliano esisteva già un villaggio etrusco, e adibite ad attività produttive quando iniziarono ad arrivare i primi nuclei di Ebrei. Questi erano in fuga dalla Spagna e dai territori annessi dopo la cacciata del 1492, ma anche da Roma in seguito alla bolla del 1555 di Paolo IV. Tali norme arrivarono purtroppo anche nella contea di Pitigliano dopo l’annessione al Granducato di Toscana, ma nel frattempo era già sorta una Sinagoga, una delle cinque presenti in Toscana e una serie di locali ad uso della comunità, come il bagno rituale (il Miqvè), il forno delle azzime rimasto in funzione fino al 1938, il macello, la tintoria e la cantina Kasher. Il vino kasher è ancora prodotto a Pitigliano, nella cantina sociale del paese, insieme allo sfratto, tipico dolce della tradizione ebraico-pitiglianese.
Borghi ricchi di storia e fascino, che aspettano solo di essere scoperti!
Articolo di Giada Pellegrini